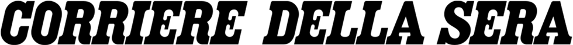Ospedali del cuore
di Marco Celati - Mercoledì 12 Giugno 2024 ore 08:00

Ritornare a casa mi ha provocato il pianto. Restituire luce alla stanza, ritrovare le cose al loro posto, gli oggetti, le abitudini: indossare le mie giacche intramontabili, inventarmi di nuovo una fretta che non c’è. Eppure è tutto qui, un monolocale, e poco o niente alla fine resta da fare. Quanto alle giacche ancora non posso indossarle e presto non sarà più stagione. Mi affaccio al terrazzo e guardo il giardinetto sottostante: piccoli fiori gialli punteggiano le erbe incolte e qua e là si accendono a macchie, le coloriture rosse dei papaveri. Imbroglio il tempo pensando come sarebbe se quell’appartamento al piano terra fosse stato mio. Dell’erba tagliata si sarebbe sparso il sentore e siepi di alloro l’avrebbero cinto, o gelsomini odorosi, di quelli che celano la vista delle villette sulla strada e stordiscono al passaggio. Illudersi di fare meglio degli altri o essere migliori di quello che siamo è una prerogativa degli uomini. Noi siamo un sogno di noi, l’ombra di una vita.
La sera piego la testa sul tavolo sopra le braccia giunte e respiro a fatica. Il corsetto stringe il torace. Ho problemi a concentrarmi e conservare l’attenzione per leggere o scrivere. La mia percezione è alterata dalla costrizione post operatoria di questa ingombrante “toracera” che mi comprime lo sterno diviso e in qualche modo il cuore, che in qualche modo, oltre al cervello, c’entra nelle cose che si pensano, si dicono e si scrivono. Si tratta del retaggio di uno strumento di tortura: nel Medio Evo, di sicuro, ci saranno stati aghi per tenerlo più fermo e stretto alle carni. Essendo abolita la tortura e la pena di morte -in Toscana fummo i primi- gli aghi li hanno tolti, ma la costrizione resta. Dice li fanno solo in Austria e ci sarà una ragione: sono tedeschi, con rispetto, solo loro potevano.
Se mi assopisco mi tornano in mente le notti insonni in ospedale, scandite dal passaggio delle ore che non finiscono mai. Anche a casa non riesco a dormire. Devo farlo supino e io dormo su un fianco da quando ho avuto coscienza di vivere e ormai sono settantaquattro anni. Ma non posso farlo, di stare su un fianco: lo sterno si deve richiudere, quarantacinque giorni ci mettono le ossa a risaldarsi -mi ha detto il chirurgo- tenga la toracera giorno e notte, almeno fino a fine maggio. Nel dormiveglia vengono a farmi visita i compagni di camera degli ospedali: i loro volti, le loro storie, i ricordi. La sofferenza unisce gli uomini più del piacere. Thanatos è più forte di Eros. Eros scuote le nostre anime -come scrive Saffo, tradotta da Quasimodo e ripresa da Scalfari- ma non siamo certi di amare, di morire sì, e questo ci atterrisce e ci unisce. Siamo come foglie che cadono, mentre altre nascono. E in questo avvicendarsi di creature, il senso del dileguarsi ci accomuna con la cognizione e la paura del dolore.
Un mese passato tra un ospedale e l’altro: al CNR di Pisa, da lì in ambulanza all’Ospedale del Cuore di Massa, poi di nuovo in ambulanza al CNR e finalmente a casa. Un intervento programmato, non urgente, ma necessario. Tutto mi sarei aspettato, fuorché il cuore. Credevo anzi, a parte ciò che del cuore si attribuisce ai sentimenti, che il muscolo cardiaco fosse un mio punto di forza. Da giovane avevo fatto sport: campestri, atletica, giocato a calcio, nuotato per lunghi tratti in mare o vasche su vasche in piscina senza avvertire granché la fatica: 55 battiti, a riposo. Un soffio al cuore, ma è prerogativa di tutti gli sportivi, questo il responso degli elettrocardiogrammi a sforzo per le prove competitive. Finché anni fa, in età senile, durante un ricovero in ospedale, non ricordo più per cosa, un giovane dottore, auscultandomi, scommise su un prolasso mitralico del sottoscritto e, riempitomi di elettrodi e consultati i macchinari, vinse la scommessa. Che devo fare, chiesi, si faccia controllare il cuore con regolarità, rispose. Quando un dottore ti dice questo, saggio sarebbe stato dargli retta, ma figurarsi, io, un atleta! Sarà un dono di natura, come diceva la mia defunta mamma a proposito del setto nasale leggermente storto, che in effetti non ne alterava la bellezza del viso. Vennero altre operazioni, prostata, ernia inguinale, c’era stato il Covid, fatti tutti i vaccini. Fin qui tutto bene. Ma lo diceva anche chi precipitava dal grattacielo, passando da un piano all’altro.
Qualche mese fa di notte, a riposo, il cuore prese a scuotermi il petto, molto di più dell’anima Eros, togliendomi il fiato. Martellava impazzito, nelle tempie, in gola, sembrava volesse uscire da me. Questo affanno durò una settimana. Quella dopo andai dal medico, e poi all’ospedale Felice Lotti -felice e filantropo, buon per lui e per noi- dove un bravo medico, responsabile dell’UTIC, dopo un lungo e accurato esame, mi disse, mi dispiace, ma il suo cuore non va, la valvola mitralica così così, quella aortica non chiude e la radice dell’Aorta è prolassata, a rischio di aneurisma. Che devo fare, chiesi, si deve operare, rispose. Il ventricolo sinistro già ne risente, dopo sarebbe peggio. Dalla sinistra mai una gioia, pensai e chiesi, dove. Fra le ipotesi che il dottore fece, quella di Massa, ospedale specializzato in cardiochirurgia, sembrava la più indicata. Anche il mio medico pensava altrettanto e così prendemmo la via della Fondazione Monasterio: CNR di Pisa e OPA di Massa. Mi sottoposi a nuove visite da uno dei valenti cardiologi dell’entourage del CNR che confermò e precisò la diagnosi, iscrivendomi nelle liste di attesa per il ricovero alla clinica di San Cataldo a Pisa per la preparazione pre operatoria e l’intervento a Massa.
Questo l’antefatto a cui, come in ogni storia che si rispetti, seguono inevitabilmente le circostanze, il fatto e le conseguenze. Le circostanze sono ciò che succede intorno, sopratutto le persone che ti capita di incontrare. I vicini di letto con cui condividi la stanza e l’ansia di trovarsi lì, quando non il dolore. Anche senza essere troppo “entranti”, alla fine ci diciamo le cose, ci si confida come ci conoscessimo da sempre, forse proprio perché sappiamo che non è così e non sarà così, una volta dimessi. Che molto probabilmente non ci vedremo più e ognuno seguirà la sua vita, nella buona o cattiva sorte, come si dice degli sposi. I nostri nomi e cognomi sono scritti a pennarello nella testata attrezzata sopra i letti, i medici parlano delle nostre patologie in presenza dei vicini di stanza, la privacy viene, seppur in maniera contingente, trascurata, ma è meglio, più umano e rassicurante, che sentirsi elencare per numero, come fossimo internati.
Pino, carrozziere del Valdarno, conosciuto durante i giorni di pre ospedalizzazione a San Cataldo, al CNR, respira a fatica, ha un enfisema. Anche di questo si occupano qui. È magro, più giovane di me, ce ne cominciano ad esser pochi più vecchi. Mi ricorda il babbo che aveva i polmoni così malridotti che ne morì: era stato un fumatore accanito. Non glielo dico, però lo chiedo a Pino, se anche lui fuma, risponde che sì, un tempo, ma ha smesso da tanto. È già stato ricoverato al CNR e poi mandato per la riabilitazione all’Ospedale di Volterra. Ma stavolta non ci vuole andare, troppo tempo via da casa, dall’officina che il padre con sacrifici ha messo su -ogni mattina da Pontedera ci andava in bicicletta- troppo tempo lontano dai familiari che la portano avanti al suo posto. E non vuole saperne della bomboletta portatile dell’ossigeno, se ne vergogna con gli amici, i figli, al lavoro. Inutilmente, con presunta sapienza, gli dico che non c’è da vergognarsi dei nostri limiti e che chi ci vuole bene capisce, ma non sembra convinto. Non lo sarei neanch’io. Alla fine la spunta e si accorda con i sanitari per un compromesso onorevole e speriamo salutare, farà da sé la riabilitazione e terrà l’ossigeno portatile, ma soltanto in casa. Lo dimettono poco prima che io sia trasferito a Massa, la mia partenza ritardata da interventi più urgenti. Mi faccio dire dell’Officina, il posto, prometto che, ristabilito, lo andrò a trovare, ma chissà se lo farò. Chissà se è giusto o quantomeno opportuno, ritrovarsi dopo aver penato insieme, forse quello che vogliamo veramente è dimenticarlo, dimenticarci.
Arrivato all’Ospedale del Cuore di Massa, mi assegnano alla stanza numero uno, dove c’è già un paziente. Un paziente particolare, dà istruzioni al personale che gli pratica le cure circa il modo migliore di prelevare il sangue, fa il calcolo delle medicine di cui conosce dosaggi e funzioni. E il bello è che tutti lo ascoltano. E così, rispettato, parla anche al cardiologo responsabile del reparto. Si presenta, facciamo conoscenza: cardiochirurgo, professore ormai in pensione, è stato, diversi anni fa, il primo direttore generale dell’Ospedale in cui adesso ci troviamo e in cui per curarsi il cuore, come per deformazione professionale, è dovuto tornare altre volte. Mi racconta del celebre Azzolina, il chirurgo che operava i “bambini blu” con gravi deformazioni cardiache. Aveva mani fatate, riusciva a chiudere con esito positivo operazioni nella metà del tempo dei colleghi. Pessimo carattere però, come molti geni. Anche il professore era specializzato in cardiochirurgia infantile. Mi dice che quando, su spinta della Regione Toscana, fu manifestata l’intenzione di fondare l’OPA di Massa, per creare, con CNR e Fondazione Monasterio, un centro di eccellenza per il cuore, distinto e distaccato dal NOA, l’Ospedale Massese, solo il Sindaco era d’accordo. Un classico. Il Consiglio Comunale vacillava e la popolazione era assolutamente contraria: temevano che si indebolisse il loro ospedale. E invece il nuovo, una volta realizzato con moderni parametri architettonici e dotato di una strumentazione all’avanguardia, fu un arricchimento e non solo per il territorio e la Toscana, ma a livello nazionale ed oltre. Furono fatti bandi per attrarre professionalità, infermieri e medici, da tutta Italia e da tutta Europa. E da ogni dove, oltre che dalla Regione, arrivavano pazienti. Mi raccontò di una volta che, per un trapianto urgente di un bambino, dovettero utilizzare un cuore, che andarono a prendere in Spagna, di un ragazzo un poco più grande. L’intervento riuscì, ma non poterono chiudere immediatamente la cassa toracica. Il bambino tornò in terapia intensiva con una gabbietta sullo sterno ancora aperto. Successivamente il cuore si adattò e l’operazione fu completata. E alla fine aggiunse, con giustificata e compassionevole fierezza, quel bambino è un uomo e vive ancora.
Ecco io penso, che con tutto ciò che si può dire dei ritardi, dei problemi, delle liste di attesa, della nostra situazione sanitaria, siamo fortunati ad avere una sanità pubblica generalista, cioè rivolta a tutti, qualsiasi siano le condizioni sociali di ciascuno. E più che una fortuna è una conquista. In altri Paesi avrebbero verificato che assicurazione abbiamo per intervenire. A me, massimo massimo, avrebbero dato due pasticche e prescritto altre, purché me le comprassi. Possiamo ritenere che in sanità occorra più il dottor Manson, il medico popolare della comunità, ricordate “La Cittadella” di Cronin? Ci fu anche uno sceneggiato per la televisione con Alberto Lupo negli anni ‘60. E occorra meno il Dr.House della serie televisiva Medical Division. Più umanità e meno tecnica, insomma. Ma in realtà ci vogliono entrambe le cose e sopratutto centri specializzati di eccellenza. Ricordo che in passato si è discusso sulla limitazione della spesa per l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici di diagnostica: il cardiocolor doppler cardiaco ad esempio, a cui tutti avrebbero fatto ricorso, anche in maniera inappropriata, aumentando i costi. Questa era l’argomentazione. Ebbene, l’ecocardio è divenuto un mezzo insostituibile per la diagnosi delle cardiopatie. È quello che è stato utilizzato più volte per capire la mia patologia e controllare l’esito dell’intervento. È che, al contrario, è un delitto risparmiare sulla salute delle persone. Così come sui livelli di istruzione. E se c’è un senso nel deprecare e combattere l’evasione fiscale e nel pagare le tasse, adeguate e proporzionali, ma certe come solo la morte, è proprio questo: curare, difendere la vita e la conoscenza. Vivere e sapere di più perché siamo al mondo e che ci stiamo a fare. Lo dico io che al mondo non ho mai saputo starci. Il professore viene dimesso prima che io sia operato dopo qualche giorno di rinvii per casi più urgenti del mio. Torna a casa. Ci salutiamo e mi dice, non si preoccupi, è in buone mani.
E mattino presto, sono nudo docciato, rasato e con un ridicolo grembiulino verde allacciato sul dietro. Ad una delle due infermiere che, in serie, mi stavano rasando, avendola sentito parlare di prossemica, chiedo: come fa allora ad avere contatti con i pazienti? Risponde che non ha nessun problema in questo senso, solo non gli piacciono le persone che non rispettano il tuo spazio personale, quelle che ti toccano ripetutamente per parlarti, ad esempio. E forse l’infermiera prossemica è infastidita anche da questa mia osservazione e interferenza nei suoi confronti. Comunque la capisco, ne conosco anch’io qualcuno di quel tipo. Abbraccio la mia compagna e uno dei figli che prendono la borsa con cellulare e indumenti. Mi commuove vederli. Vengo barellato e spinto via. Scorrendo lungo gli ampi corridoi, entriamo in un ascensore completamente metallizzato, grande come casa mia. Gli infermieri discutono del piano ferie, presidio sacrosanto dei lavoratori, per carità, ma chissà perché ne parlano sempre tra di loro, a voce alta, mentre ci accudiscono. Ci vogliono mettere al corrente delle loro vacanze? In montagna, al mare? Quest’anno all’estero. Si scende, mi pare, in una sala grande, già affollata e in fermento per l’ora: sono le 7:30 del 15 aprile. Mi chiedono tre volte nome cognome e data di nascita, rispondo bene, li so e sono proprio io. Chiedo se anche loro sanno quello che mi devono fare. Ridono e dopo questa battuta cretina più niente.
Sono in un letto e sto riprendendo conoscenza. Tengo gli occhi socchiusi. È andato tutto bene, come sta, ha dolore, mi dice una voce femminile, chiamandomi per nome. Per questo lo chiedono tre volte. Insomma, rispondo, mi fa malissimo la vita. La morfina mi fa vomitare. Ho due conati, il torace sembra aprirsi. La dottoressa mi dà per endovena un antidolorifico diverso. Si abbracci, mi dice, se tossisce o le viene da rimettere. Cosa poi? Sono digiuno. Il letto della terapia intensiva, dove mi dicono che ci troviamo, ha un materasso che si gonfia e si sgonfia al centro e ai lati per prevenire problemi da decubito e mi rilassa un po’, alleviando il mal di vita. Ci sono altri operati nel padiglione e tende che si aprono e si chiudono. Altre lettighe arrivano e si capisce dalla concitazione che sono urgenze. Una tenda si chiude e non si riapre più. Meglio non chiedere, sono anche senza la protesi dentale e senza fiato per articolare un discorso. Sono agganciato alle flebo, ho qualcosa al collo, ho due tubi di drenaggio che mi partono dalla pancia, il fastidioso catetere, l’ossigeno insufflato nelle narici. Sono immobilizzato. Non ho una precisa cognizione del tempo che in questo risveglio sofferente, sembra interminabile, come una lunga, lunghissima notte. Domani salirà in reparto, lì hanno letti migliori, mi dice l’infermiera. Immagino, penso, ma non lo dico. Ho dimestichezza con letti e guanciali ospedalieri, lo so che ci si sta male. Mi piaceva quel materasso mobile.
L’operazione è durata complessivamente dalle 7:30 alle 16:30. Il dottor Farneti, il cardiochirurgo che mi ha operato, mi ha mostrato, ancora intubato, alla compagna ed al figlio e dicono che non ero bello da vedere. L’intervento è riuscito. Mi hanno tolto la radice dell’Aorta sostituendola con una protesi vascolare, un tubicino di “dacron”, un tessuto poliestere, e mi hanno inserito una valvola bio, al posto della mia valvola aortica che non funzionava più. Un bel lavoro di taglia e cuci. La valvola mitralica pensano che avrà minori problemi con il funzionamento corretto dell’aortica. Se no, tuttalpiù, si farà più in qua un intervento, ma non invasivo, attraverso la femorale: normale amministrazione. Le eccellenze d’altronde ragionano così. La valvola che mi hanno messo è di maiale. Dice che i maiali hanno il cuore simile al nostro. Ci sarà una ragione? Così se un giorno, amici e compagni, mi sentirete grugnire, niente paura, sono sempre io: un uomo con un cuore in parte suino, una chimera. Mi viene in mente Kazuo Ishiguro, il Nobel giapponese, e il suo “Non lasciarmi”. Nello sconvolgente romanzo, in un futuro distopico, l’autore immagina una società in cui si “allevano” nei collegi donne e uomini creati in provetta, destinati a fornire organi di ricambio per le persone viventi, fino ad essere soppressi, terminati. In fondo in qualche fattoria di maiali si fa lo stesso per noi, anche a rafforzamento del detto che del maiale non si butta via niente, tantomeno le valvole cardiache. Un giorno spero che con l’uso delle cellule staminali si possano riprodurre i nostri organi personali, così che ne abbiamo di ricambio, senza far male a nessun essere vivente. Pochi giorni fa ho addentato un panino al prosciutto e non ero del tutto a mio agio. Mi sentivo quasi un cannibale. La figlia della mia compagna, vegetariana per scelta etica, è inorridita. Io -cinico come Antistene di Atene e Diogene di Sinope, suo allievo- ho pensato ai progressi ottenuti dalla scienza medica, mi sono fatto forza e ho finito il panino, del resto frugale. A proposito, la valvola bio dura quindici anni, chi dice meno, chi dice di più, ma questa è la garanzia. Non è bello conoscere in anticipo la propria scadenza. Fra quindici anni ne avrò ottantanove. Più della speranza di vita media di un uomo di sesso maschile. Devo sperare nell’ulteriore progresso della medicina per eventuali interventi di “manutenzione straordinaria” non invasivi? Posso sperare di non morire di cuore? E quanto posso sperare di vivere? E come.
Che non riesco a dormire supino è stato già detto? Ora poi, appeso a tutti quei tubi in entrata e in uscita, con lo sterno diviso in parte e scrocchiante ad ogni movimento, passavo la notte a guardare l’orologio, controllando se fosse fermo e ripensando a tutti i miei peccati, quelli che dovevo aver fatto per ritrovarmi così. Smaniavo, diventavo molesto con continue richieste al personale di gocce, di qualcosa per assopirmi, di essere sedato. Mi faceva compagnia “Dora Markus”, la poesia di Montale che ripassavo sottovoce a memoria. Dall’inizio, “Fu dove il ponte di legno/ mette a porto Corsini sul mare alto…”, fino alla fine, “Ma è tardi, sempre più tardi”. Che tardi era tardi, ma di dormire non se ne ragionava. La privazione del sonno rientra storicamente nelle pratiche della tortura. Andavo in bianco e quando andava meglio più di un’ora o due a notte non riuscivo a dormire e questo per tutti i giorni che sono stato relegato al letto, senza trovare posa tra guanciali e capezzale perché di posa ne avevo una sola: a pancia in su. Poi i guanciali ospedalieri sono un attentato alla cervicale e i letti in genere troppo corti. Negli ospedali gli effetti letterecci, per dirla in gergo da accasermamento militaresco, andrebbero migliorati. Il catetere vescicale, inserito dal pene, era quello che mi dava più fastidio. Sono stato operato di prostata, so cosa dico. I maschi non sopportano questa cosa. Se avessimo dovuto noi partorire i figli dal nostro apparato genitale, l’umanità si sarebbe già estinta da un pezzo. L’Antropocene non sarebbe mai giunta e la natura indifferente, piante e animali, avrebbe ripreso, libera e non oppressa dalla razza umana, a rifiorire e prosperare. Con malcelata soddisfazione dei giovani imbrattatori di opere d’arte di “Ultima Generazione” che l’avevano predetto e sarebbero stati davvero gli ultimi, tuttalpiù penultimi. Facciamo terzultimi e non se ne parla più.
Avanzando nella convalescenza una mattina presto un’intraprendente infermiera, un angelo, annunciò: buongiorno, ieri la dottoressa ha tolto il drenaggio, ora togliamo il catetere. E così fu. Una volta liberato da quella costrizione, chiesi di alzarmi dal letto. Guardi avanti, le gira la testa? Fosse il male della testa, pensavo, ma non lo dissi, perché anche la testa effettivamente un po’ girava, però volevo mettermi a tutti i costi in poltrona, cambiare posizione, cercare ristoro, riposo. E così andò. Poi mi fu imposto di nuovo il letto. Sennonché più tardi passò il turno: dottore giovane, ricciolino, severo e algido che prendeva appunti e disponeva, infermiera magra e solerte che ragguagliava. Perché è stato tolto il catetere? Sentii dire e un brivido mi corse lungo la martoriata schiena. Niente di buono, pensai. Infatti di lì a poco, o così mi parve, perché anche secondo Einstein il tempo è relativo, l’infermiera solerte tornò: ha urinato, chiese. Il pappagallo giaceva sconsolato e vuoto sulla sua mensola. Ma è poco che mi avete tolto il catetere, rispondo. Niente affatto è già un’ora. Passa in fretta il tempo quando ci si diverte, ha ragione Einstein, penso, ma mi guardo dal dirlo. Beve, caro? La bottiglia da un litro e mezzo, al contrario del pappagallo, giaceva piena sul comodino. Non bevo molto, anche se dovrei. Male, ripasso tra un’ora, se quando torno non ha urinato rimettiamo il catetere. Beva, caro, beva! Dopo mezz’ora avevo già scolato la bottiglia ed ero in bagno a tifare per me e per il pappagallo. Con fierezza e sospirando per lo scampato pericolo, lo esibii, pieno a metà, all’infermiera quando ritornò. Fanculo il catetere, cara!
La convalescenza è stata dura e più lunga del previsto: forse la mia non più giovane età, forse il caso. Chissà. Fatto sta che una notte, qualche giorno dopo l’operazione, il cuore riprese a martellare come un ossesso e l’aria a mancarmi. Il monitor sopra il letto si era acceso di un rosso inquietante emettendo un allarme per nulla rassicurante. Così probabilmente aveva fatto anche quello della consolle centrale, dove ci osservava il personale sanitario di servizio: non feci in tempo a premere il pulsante per chiamare che accorsero. Sembrava di essere in una di quelle serie tv di medicina. Il cuore è impazzito, che succede, chiesi. È normale risposero, fibrillazione atriale, può succedere dopo l’operazione, il cuore si infiamma e fa così. Succede a tutti, chiesi ancora. Circa il 30%. Peccato non essere nell’altro 70%, pensai. Maledetta vocazione minoritaria! Per le eccellenze è normale, per gli scarsi no, è dolore e spavento. Mi riempirono di Cordarone, un farmaco potente, attraverso la flebo e durò diversi giorni.
Si può scherzare su tutto: vita, morte, amore, destino, divinità persino, ma della morte si ha paura. Ci diciamo che fa parte della vita, che in fondo non ci tocca: quando ci siamo non c’è la morte e quando c’è lei non ci siamo più noi. Si sa che tutto si trasforma nella natura delle cose, tutto sorge, dilegua, diviene. E che noi alla fine siamo come creature di un sol giorno, esseri di una rapida vita. Però, a meno di non credere o sperare nella vita del mondo che verrà, e non è il mio caso, la morte non è un continuum, la morte è un muro che si oppone alla vita e la termina. Se ne può placare il dolore, l’inutile e crudele sofferenza con una buona legge che consenta un trapasso civile, circondati dai propri cari. Assistere la fine, come si assiste il principio, la nascita. Ma pochi accettano la fine del conto alla rovescia di cui pure conosciamo esistenza ed esito. Ripeto sempre «bel mi’ mori’», ma non è spavalderia, è scongiuro. Lo diceva sempre mio padre che infatti è morto: giovane in fondo e ancora più giovane la mamma. Siamo stati orfani presto. Ecco, quella notte e i giorni e le notti che seguirono ho creduto di morire. Male, solo, improvviso, lontano dai miei affetti. Pensavo: l’operazione è riuscita, il paziente è morto. Accidenti a me, cosa ne scrivo a fare, morirei per una battuta. Non sono morto, per fortuna e capacità dei medici. Un bel giorno il cuore si è deciso a placarsi e di lì a poco mi hanno dimesso da Massa per indirizzarmi di nuovo al CNR a Pisa, dove rimettermi bene in sesto. E allora ci siamo salutati con i compagni di stanza. Insieme abbiamo condiviso momenti di sofferenza e i ritmi dell’ospedale, i prelievi, le visite, il riordino dei letti della camera, le pulizie, il bagno, i pasti, non proprio buoni all’OPA con tutta franchezza. Ci siamo raccontati un pezzo delle nostre vite per presentarci, dire chi siamo, chi siamo stati ed ingannare il tempo e forse anche noi stessi. Così. Di sfuggita. Il mio era un intervento programmato, ma ne ho visti diversi, oppure ho saputo di loro, salvati in extremis da infarti o altri gravi accidenti cardiocircolatori. Per ciascuno di loro l’ospedale è stata la salvezza, la possibilità di proseguire la vita per se stessi e i propri cari.
Vinicio abita vicino a Firenze, commercia in prodotti sanitari, da quanto si capisce perché se gli parli va della sua. È il primo che vedo con una toracera. Ha avuto un’operazione come la mia. È già in fase di dimissioni, va via presto, il primo fra noi della camera con quattro letti del reparto di subintensiva. Anche il mio babbo si chiamava Vinicio.
Mauro era parrucchiere, poi il Covid, la burocrazia, il fisco... Ora si occupa di prodotti di bellezza per donne. Diverse infermiere gli chiedono consigli. Era a cena si sente male, un infarto. Lo portano in ambulanza a Massa e lo operano d’urgenza, è salvo. Ha una brutta tosse che gli fa male al torace. È una persona simpatica, sensibile, forse ansiosa, si capisce dalla gentilezza e qualche inciampo nel parlare. Pensavo al meraviglioso film, “Il discorso del Re” di Tom Hopper con Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter, la storia vera del padre della Regina Elisabetta, un grande re anche per me repubblicano. Ma mi sono guardato da chiedergli se l’avesse visto o consigliargli la visione. Lo stavano dimettendo, ma all’ultimo minuto l’hanno mandato al Versilia per terminare la convalescenza. Ci siamo messaggiati: all’Ospedale della Versilia non si trovava bene, magari si mangiava meglio, che ci voleva poco, però a Massa, altra professionalità e ottima compagnia. Al Versilia si sentiva depresso e appena gli è stato possibile è venuto via, è tornato a casa e sta bene. Mi fa gli auguri, contraccambio.
Giovanni fa il contadino vicino ad Aulla. Ha dolori al petto, sospettano una broncopolmonite e lo ricoverano all’ospedale di Pontremoli dove per questo gli praticano le prime cure. Però si rendono conto abbastanza presto che si tratta di un principio d’infarto. Trasferito e operato a Massa. Credo sia più anziano di me, ma porta gli anni benissimo, capelli bianchi, bella presenza. Reagisce bene alla fase post operatoria, meglio di me. Durante le notti insonni, l’ho visto spesso, anche lui, guadagnare la poltrona accanto al letto e cercare riposo. Non l’abbiamo sentito mai lamentarsi. Lunigianese, apuano, tempra forte, parla in dialetto con i suoi e non è toscano, è un’altra lingua, ligure, emiliana. Non sempre comprendo, ma è un’inflessione dialettale che ha un suo andamento, un suo scandire. Come quando senti una canzone in una lingua straniera che tutte le parole non le capisci, ma la musica ti piace. Come quando approfittai della presenza di Milo De Angelis, poeta, traduttore di Lucrezio, invitato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, per fargli recitare per me solo, abuso e raro privilegio, una sua poesia da “Distante un padre”, in dialetto monferrino, quello della madre. S’intitola “Staseira”, stasera, e finisce così: “A sent che la poesia/ l’è tüta lì: fà l’univers con gnente”, forse la poesia / è tutta lì: fare l’universo con niente. Meraviglia!
Salvatore si era sentito male, con l’apparato cardiocircolatorio rimesso in sesto arriva dalla sala operatoria affamato. Gli dicono può bere, ma poco e poi al massimo un po’ di brodo. Ma lui dà in escandescenze, non sente ragioni, vuole mangiare. Ho la tiroide, dice. La moglie e le sorelle inutilmente cercano di calmarlo. Si sbaffa quattro panini con la marmellata e chissà cos’altro. Per sua fortuna ci deve essere una qualche divinità compassionevole, un Dio protettore di temerari e incoscienti e il suo apparato digerente, nonostante l’anestesia, funziona già. Passa la notte a emettere lamenti e contenere eruttazioni, ma ce la fa. E così la mattina il nostro Salvatore, siciliano di origine e viareggino di elezione, è più calmo e bello vispo. Per qualsiasi intervento che deve subire, rilascia un lamento di avvertimento: ho la pelle sensibile, dice. È un simpatico e scaltro casinista, legge i nomi nel cartellino identificativo di infermiere e infermieri e se li ricorda, così chiama tutti per nome e tutti promuove dottore. Quando nell’ora di visita arrivano moglie e sorellanza è uno spettacolo, un teatro! Lo dimettono presto, lui è contento, vuol tornare alla sua vita, al bar: un cicchetto con gli amici e magari una sigarettina. I familiari sono un po’ meno certi di questa buonuscita e chiedono ragguagli. Ma è così, alla fine il dottore, quello vero, s’incazza e dice che va tutto bene e consegna loro la lettera di dimissioni. Visto? Siete dottori voi? Commenta Salvatore, rivolto a moglie e sorelle. Ci mancherà Salvatore nei giorni a seguire, i suoi lamenti e commenti, quella capacità della gente semplice di essere empatica con le persone, di essere senza remore, folle, vera, popolare.
Francesco arriva la notte, un primo intervento salvavita a cui ne seguirà un altro, il giorno successivo. Uomo corpulento, massiccio, dai boschi della Lunigiana. Tutto il giorno si era dato da fare, lavorato, andato a funghi, spaccato legna, poi a metà pomeriggio, visto il bel tempo, da appassionato motociclista qual è, inforca la moto da cross e sale sul monte che sovrasta la sua abitazione. Arrivato in vetta avverte un dolore interno, come un mal di denti nello stomaco gonfio e nel petto, così lo descrive. Scende giù per i tornanti stringendo i denti, arriva a casa, sua sorella, infermiera tra l’altro, chiama l’ambulanza che lo porta a Massa a sirene spiegate. C’è un fattore ereditario, diversi familiari hanno sofferto di cuore. Dal duplice intervento si riprende bene, avrà appena una cinquantina d’anni. Dopo la partenza di Salvatore, forse è il più giovane tra noi. E, diversamente da noi, la notte dorme e a volte russa sodo, ma il giorno gli piace parlare e racconta. Ha fatto tanti mestieri, ora lavora in un allevamento di trote. Ci dice di quando una piena del fiume devastò le vasche e ci rivela che le trote salmonate sono così solo per quello che gli danno da mangiare. È “il grande cacciatore”, ci fa vedere nel cellulare le foto dei cinghiali uccisi, ci parla delle battute, dei cani usati nella caccia e di quello sventrato da un grosso cinghiale. Le immagini sono forti e le zanne del verro anche in foto fanno impressione. A sentirlo e a vederlo pensi che uomini e cinghiali siano una razza e che a mani nude lui possa affrontarli. La figlia della mia compagna per l’operazione mi aveva regalato un cinghialino di peluche che tenevo sul comodino. Anche tu cacciatore, mi chiese. Mai avuto un’arma, risposi, è solo un portafortuna. Rimase deluso, penso di avergli dato un grande dispiacere. Con Giovanni parlavano in lunigianese, capivo poco o nulla, ma mi piaceva starli a sentire.
In seguito a ripetuti rinvii, alla fine con un amico di Pontedera ci siamo trovati insieme a Massa. Lui doveva fare una coronarografia con angioplastica: dalla Tac era risultato che le coronarie avevano stenosi, restringimenti in più punti. La causa sarebbe il diabete con cui convive da tempo. Mi viene a trovare, a sorpresa: ha appena fatto la coronarografia e gli hanno detto che no, non importa intervenire. Più avanti semmai. Meglio così! Sono contento per lui. Gli chiedo com’è stato, se ha sentito dolore. Mi risponde che no si sente avanzare dentro qualcosa, solo un lieve fastidio. La coronarografia l’ho dovuta fare anch’io al CNR in preparazione all’operazione, però ho chiesto di essere sedato. Sarebbe la prima volta, mi ha detto l’anestesista, nella vena non ci sono terminali nervosi, ci passiamo un piccolissimo catetere, non sentirà niente. Non importa, ho risposto, io il dolore me l’invento. Ma dura poco, se non troviamo ostruzioni. E se le trovate e dovete intervenire? Io sveglio non reggo, sono facilmente impressionabile, mi conosco. Mi spaventano perfino i macchinari, gli strumenti. Quando mi levavo il sangue da ragazzo mi svenivo, non per il dolore, al pensiero del sangue che scorre. Ancora oggi che sangue me ne sono levato assai e sono stato trasfuso, non devo guardare, giro la testa dall’altra parte. Non sono un cuor di leone, nella vita di coraggio ne ho avuto, ma non ne ho per queste cose. Che c’è di male nell’avere paura? Le sofferenze fisiche o psicologiche, se con la medicina antica o moderna si possono evitare perché non farlo? Il dolore non ci fa uomini migliori, non ci redime. Sopportare stoicamente se necessario, ma non oltre. E poi essere sedato è un mio diritto e vi prego di farlo, ho detto. Mi hanno sedato, forse un oppiaceo, chissà, ho dormito e quando mi sono svegliato era già tutto passato. Come Noodles-De Niro in “C’era una volta in America” di Sergio Leone. Mi hanno preso tutti per il culo, ma era previsto, un effetto collaterale. L’indomani l’amico è stato dimesso.
L’ultimo arrivato si chiama Gennaro. Famiglia numerosa di origine, tanti figli e poco lavoro. Dalla costiera Amalfitana parte giovane con la valigia di cartone -lo racconta lui- in giro per l’Italia. Si ferma in Toscana, a Viareggio apre un negozio di articoli alimentari, una drogheria che rifornisce anche gli altri esercenti viareggini, quelli della passeggiata. Il commercio rende bene, si può permettere anche dipendenti. Esposito mette su famiglia, ce l’ha fatta. Come tanta gente operosa del Sud ha partecipato e dato impulso al boom economico del Paese. Ora è in pensione. Ha fatto altre operazioni per il cuore e questa è l’ultima o così spera.
Alla fine venne anche il mio turno di lasciare l’Ospedale del Cuore. Dove, in effetti un po’ di cuore ho lasciato: un pezzetto di Aorta, la valvola, i ricordi delle notti insonni e dei compagni di stanza e di sventura. La fibrillazione era cessata, anche se i battiti non erano proprio regolari, a volte troppo alti o troppo bassi. Quelli bassi a 40, che ce li aveva Fausto Coppi, quando scalò il Sestriere. Fui rispedito in ambulanza al mittente, al CNR. per rimettermi in sesto. A Pisa ritrovai gli infermieri che avevo conosciuto: bentornato, come va, tutto bene, forza, il più è passato. E incontrai nuovi compagni di stanza. Quella che mi assegnarono aveva due letti. Uno era già occupato.
Fabio originario di Brescia, ma da tempo insediato in Lunigiana, versante ligure. Imprenditore costruttore, lavoro, pensieri, responsabilità, stress. Robusto, sui cento chili, ma ben portati. È interista, parte con gli amici per festeggiare lo scudetto, a Milano arrivano in anticipo, vanno in un bar a rifocillarsi e far passare il tempo. Sta parlando nel bar e questa è l’ultima cosa che ricorda. Si risveglia al San Raffaele, in terapia intensiva con quindici punti nella nuca e due costole rotte. Gli dicono che è stato morto per cinque minuti. Non infarto, ma arresto cardiaco. Il suo cuore si è fermato. La fortuna è che nel bar c’erano un defibrillatore e, fortuna nella fortuna, una persona che sapeva come farlo funzionare. Lo ha riportato in vita. Poi sull’ambulanza due infermieri energumeni hanno completato il massaggio cardiaco a scapito di un paio di costole. Fornisce le sue generalità, anche se non lo ricorda, la testa è a posto. Gli chiedo se di quei cinque minuti ha qualche sensazione. Nessuna, risponde, vuoto. Hanno di recente installato nelle camere televisori più grandi, una donazione o un investimento. Insieme vediamo la partita Fiorentina Atalanta. Io tifo viola, penso che lui tenga per la Dea. È di Mantova, risponde, e io sono bresciano, impossibile. E capisco che fra Mantova e Brescia, deve essere come tra Pisa e Livorno o, si parva licet, fra Pontedera e Ponsacco. Tutto il mondo è paese. La Fiore naturalmente perde, l’Atalanta onestamente gioca meglio e purtroppo c’è poco da fare. Quella per la Fiorentina non è una fede è più una passione. Un mistero doloroso. Fabrizio deve fare un by pass coronarico. Le sue coronarie erano pressoché occluse, per questo l’arresto cardiaco. A Milano le hanno riaperte, ma una era ostica a risolversi e allora l’hanno indirizzato a Pisa per ripristinarne la funzionalità. Qui un primo tentativo di angioplastica, durato a lungo e anche fastidioso, non era riuscito e allora il by pass. Tutto bene ed è già in uscita. Tornerà al suo lavoro -il figlio ha anche un locale- ai suoi impegni che non devono essere pochi. Nel mio concetto e rispetto del mondo del lavoro, queste persone, a pieno titolo, sono comprese. È anche a loro, al loro cuore e alla loro testa, che dobbiamo questo Paese. Ci salutiamo. In bocca al lupo, evviva il lupo.
C’è una poesia di Luzi “La notte lava la mente” che rimando a memoria. “Poco dopo si è qui come sai bene,/ file d’anime lungo la cornice,/ chi pronto al balzo, chi quasi in catene./ Qualcuno sulla pagina del mare/ traccia un segno di vita, figge un punto./ Raramente qualche gabbiano appare”. A noi viene a trovarci, un gabbiano. Vola sul cornicione di là dalla finestra. Batte al vetro con il becco, qualcuno deve avergli dato del cibo in passato e lui se ne ricorda. Il vetro è oscurato dall’esterno, noi possiamo vederlo, ma lui non vede noi. Così restiamo in quella vicinanza innaturale tra uomini e uccelli. I gabbiani di città conservano il grido, il volo e un aspetto importante, ma come di nobiltà decaduta. La sua questua non va a buon fine e ad ali spiegate riguadagna il cielo.
Dopo Fabio arriva un tipo particolare. Gli affidano letto ed armadio. È inquieto, cerca nella borsa, butta tutto alla rinfusa, scaraventa la giacca sul tavolo dove si mangia, glielo faccio notare, la toglie, si scusa e sbotta, non trovo il cellulare, l’ho perso! Arriva un’infermiera che cortesemente gli porta un cellulare di servizio, ha bisogno di un caricabatterie, arriva anche quello. Comincia a chiamare la sua fidanzata, credo, le dà indicazioni abbastanza vaghe per rintracciare il suo informatico, suo di lui, che saprebbe come fare a ricercare il cellulare smarrito. C’ho tutti gli impegni, i contatti, le date. Mentre sta ancora indicando la via dove forse quest’uomo abita o lo studio, contattarne la figlia, ritorna l’infermiera. L’abbiamo trovato, l’aveva lasciato in sala d’aspetto. Raggiante, con il suo iphone riprende a chiamare, avvisa del ritrovamento, parla ad alta voce come se nella stanza ci fosse nessuno. Continua a telefonare anche quando entra un infermiere che gli dà disposizioni per l’intervento che deve fare fra poco. Deve mettersi a letto, lui chiede non passate mica dalla vena del polso, vero? Forse. Non è possibile, avverta il chirurgo, salite per la femorale. Il polso non si tocca, sono un pianista e non posso rischiare di compromettere la sensibilità della mano. È pianista, e dove ha suonato, chiede l’infermiere? In giro per il mondo, risponde, dalla Scala alla Carnegie Hall. Cazzo, penso io e sono convinto anche l’infermiere. Abbiamo un fenomeno, faccio tra me, e vado un po’ in giro perché sarà anche un pianista, ma non sopporto quell’animazione e quell’atteggiamento borioso. Mi siedo nella poltrona in fondo al corridoio, meta delle nostre passeggiate riabilitative e cerco sul cellulare, avevo visto il nome scritto sopra il letto del nuovo ospite: su Wikipedia e in rete appare un romanzo. È tutto vero: enfant prodige, oggi è un interprete della musica classica del ‘900, Brahms, Chopin, Debussy, Beethoven, Tchaikovsky e Liszt in particolare. Si è esibito come solista nelle grandi capitali, è stato diretto da Riccardo Muti, ha accompagnato l’esibizione di ballo di Carla Fracci. Torno in camera per presentarmi al “maestro”, pur sospettando che non gli sarebbe importato un fico secco, e lo trovo in maglietta e boxeur affacciato alla finestra. Stava fumando. Guardi che non si può, anche per il suo bene, se non per il mio. Lui si mette l’indice sulla bocca, chiusa a culo di gallina e mi impone un complice silenzio. Una sigarettina, suvvia! E se devo essere del tutto sincero, anche se non indenne da una punta di malanimo e malignità, la sigarettina non mi sembrava di quelle in commercio. Poi tornano gli infermieri, lo spogliano gli mettono il grembiulino per l’imminente operazione e lo mettono a letto, intimandogli di non alzarsi. Anche perché è nudo. Comunque siamo tra uomini, dice. Dal letto, avendomi assunto come suo assistente, mi chiede un favore: puoi passarmi, ti dispiace, quella bottiglia nell’armadio, ci sono i miei integratori, non posso farne a meno. Io gli passo la bottiglia semi avvolta nella carta, e noto il colore del liquido. A prima vista vino o, peggio, un liquore. Ci si attacca, poi sporgendosi fino a rischiare di cadere dal letto la ripone nell’armadio, forse perché ha capito dalla mia sorpresa espressione che un secondo “favore” non era il caso di chiedermi. Andò in sala operatoria felice, gli dovevano praticare un’angioplastica o mettere uno stent, ritornò euforico, telefonò di nuovo alla compagna dicendole che si era divertito un sacco e continuò a parlarle ad alta voce ignorando i presenti, intercalando qualche risposta scocciata all’infermiera che gli stava cercando di dire qualcosa circa il decorso operatorio. Avevo avvertito l’infermiera del fumo e degli integratori perché non respiravo bene in seguito all’operazione, stretto nella toracera, e non avevo alcuna intenzione di stare in uno scompartimento per fumatori. Quanto alla bottiglia mi aveva dato noia quella complicità estorta a mia insaputa di una cosa che non si fa negli ospedali e poteva oltretutto nuocergli, specie prima di un intervento chirurgico. Aprirono l’armadio, presero le sue cose e la bottiglia, lo trasferirono in un’altra stanza, in osservazione. Pochi giorni dopo, seppi che era stato dimesso, me lo disse un infermiere scuotendo la testa. Chissà dove si trova ora, se si sta esibendo al piano in qualche recital o concerto. Le sue esecuzioni, che ho ascoltato in rete, sono notevoli, un grande! Genio e sregolatezza. Il primo sicuro, ma anche la seconda notevole.
Il paziente che prese il suo posto era del tutto diverso. Umberto, camionista di Cecina, era venuto a curarsi un enfisema polmonare. Fumatore? Macché. Trasporto acidi e solventi per la Solvay di Rosignano, in giro per l’Italia. Lo diceva non avendo prova di questo come causa della sua patologia, ma un sospetto sì. E si capiva che in cuor suo era contrastato dalla necessità del lavoro e la possibilità che nuocesse alla salute. Ma era il suo lavoro, quello con cui da tempo viveva e portava avanti la famiglia. Riscatto e sacrificio. Quanti nel nostro Paese, e non solo?! Abbiamo parlato delle disavventure del Sindaco di Cecina e delle sue parti, sul mare. C’andavamo in villeggiatura, da giovani, anche l’ultimo anno che la mamma era viva e poi un’ambulanza venne a portarla via e ci siamo tornati i più avanti negli anni. Per raccontargli con tutta la vanagloria possibile che avevo più di sessant’anni quando ho fatto due volte a nuoto il tratto di mare dal Porto di Rosignano fino a Punta Righini a Castiglioncello e ritorno, senza fatica. Perché qualcuno ci credesse, per ricordarmelo e crederci anch’io. Ma è tutto vero e ora mi ritrovo questo cuore scassato. Buffa la vita. Umberto non fa parte del mondo del lavoro, è il mondo del lavoro. Quando vado via, perché alla fine mandano via anche me, gli lascio il segno del potere che tiene sul comodino chi ha più anzianità di stanza: il telecomando della televisione. Ciao, stai bene. Anche te.
Sto meglio, sono privo di flebo e libero di camminare, andare in bagno, tutto. Il cuore fa ancora qualche salto, ma va bene. Così mi dimettono, è la volta di finirla con i ricoveri, un mese fra tutti, e tornare a casa. A casa mia. Dove abito, insomma. Devo molto, dobbiamo molto a questi medici, infermieri, OS. Sì ci sarà qualche medico gigione oppure scostante, qualche infermiera o infermiere ciarliero, non c’è certo un ambiente asettico negli ospedali, e chissà se sarebbe meglio per curare, oltre ai nostri mali, la nostra apprensione. Ma al personale sanitario affidiamo le nostre vite in circostanze infelici e riceviamo comprensione, sopportazione, talora perfino compassione, e sempre cura e professionalità. Ci sono infermiere che ti mettono un ago in vena e non senti niente, tanto leggera hanno la mano, medici che ti spiegano quello che ti faranno, rassicurandoti per il poco dolore che proverai e che puoi sostenere. Con un’operatrice sanitaria che riemetteva a posto camera e letti al CNR ho cantato insieme. Era sarda, si sentiva dall’accento. Canticchiava e le ho proposto di cantare “Non potho reposare”. Conosce quella canzone, mi ha chiesto stupita. Certo, le ho risposto, è una bellissima canzone popolare e poi le notti che non dormivo me la cantavo nella testa. È una poesia. È vero, l’hanno cantata tanti, soprattutto i Tazenda. Indimenticabile Andrea Parodi! Ma c’è anche una bella versione, più recente, di Gianna Nannini che ha la voce adatta per quella canzone. E abbiamo preso ad intonarla: “Non potho reposare amore ‘e coro” fino a “Unu mundu bellissimu pro tene/ Pro poder dispensare cada bene. T’assicuro ch’a tie solu bramo/ Ca t’amo forte t’amo, t’amo, t’amo” . Finché è arrivata una OS pisana -anche lei si capiva dall’accento- che ha detto: o cos’è questa lagna!?
Invece devo un milione di scuse ad un’altra operatrice del CNR. C’è magari una spiegazione, che non mi giustifica, ma c’è. La notte continuavo a non dormire. Le gocce che mi davano: cinque non mi facevano niente, poi dieci, poi quindici, sempre niente. Con venti una sonnolenza di mezz’ora e poi occhi sgranati. Oggi ho smesso, con quelle dannate gocce, rischiano di darti assuefazione e te ne occorrerebbero sempre di più, per non dormire oltretutto, forse per stonarti. Fatto sta che una sera me le avevano messe in un bicchiere di plastica trasparente. Non le prendevo subito, ma a notte più inoltrata sperando che facessero effetto. Negli ospedali, si cena alle 18:30 e, anche se è salutare per il ritmo circadiano, le notti cominciano presto e sembrano infinite. Insomma nella penombra non vedo il bicchiere e lo rovescio sul tavolino che asciugo alla meglio con i fazzoletti di carta. Chiamo, arriva un’operatrice gli spiego e gli chiedo altre gocce. Mi risponde è tardi ormai, rischierebbe di dormire tutto il giorno. Magari, penso io. E poi non sono un’ infermiera e non gliele posso dare. Se ne va e io resto seduto sul letto con la testa e le braccia appoggiate al tavolino. Mi assopisco, non so. Ad un certo punto arriva di nuovo l’operatrice e mi chiede come mai sto così e non a letto. Mi spazientisco e rispondo stizzito: ma se non è un infermiera e non può farci niente, che me lo chiede a fare? Non risponde e si capisce che c’è rimasta male, prende il contenitore delle urine per andarlo a vuotare, per questo era venuta. L’indomani devo fare una radiografia al torace e un’operatrice mi spinge in carrozzella. Come sta, mi chiede, la notte scorsa mi ha trattato male e non capisco perché. Ma non mi aveva detto che non era infermiera e non mi poteva ridare le gocce che avevo versato? Non ero io, sarà stata la collega del turno precedente! Mi sono scusato non so quante volte, e mi ha detto va bene e che era di Calcinaia, ma c’era piovuta. Siamo quasi concittadini. Non mi è mai piaciuta la definizione di “pazienti”, ma la verità è che nei confronti di persone che fanno un lavoro di servizio, giorno e notte, diventiamo a volte insofferenti, sgarbati, maleducati perfino, e non so se la nostra condizione sofferente, ci assolve.
Una volta a casa ho tirato il fiato: è il caso di dirlo con la toracera che mi comprime le costole, dovevo arrivare al 31 maggio e poi avrei potuto toglierla. Così ho fatto. Ho ripreso a sgranchirmi le gambe intorno casa, mi sono fatto portare la spesa a domicilio dalla Coop, e dai miei cari, naturalmente. Mi sono comprato uno sfigmomanometro, una bilancia e un saturimetro, per misurare sfiga, pressione, battiti, peso e ossigenazione del sangue e ovviamente sono divenuto maniaco compulsivo e ipocondriaco. Se prima non controllavo mai niente, ora controllo troppo tutto. Il cuore in effetti continuava con le sue aritmie. Infatti una notte ha ripreso a fibrillare a più non posso e questa volta alle 6 mi sono fatto portare dalla mia compagna al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pontedera. E se questo racconto vuole essere onesto devo dire che non ho visto solo cose buone. Troppa affluenza ed attesa, spazi non del tutto sufficienti per cittadini, pazienti, e operatori, qualcuno lasciato troppo a lungo a soffrire, qualcun altro che si capiva che il suo medico poteva averlo preso più in cura e non indirizzato subito all’Ospedale, qualche atteggiamento di cinico adattamento al dolore altrui. Ovviamente anche professionalità, abnegazione, umanità di operatori, che vanno anche al di là dei limiti delle strutture.
A me hanno prestato le cure necessarie, tenuto sette ore sulla barella in osservazione e alla fine mi hanno praticato la cardioversione elettrica. Ti mettono due piastre adesive conduttrici, ti addormentano e danno la scossa. Come si fa con i cavetti per le batterie delle macchine. Il cuore, che va anche in virtù di impulsi elettrici, in genere si stabilizza. E così infatti è stato e sono tornato a casa. Sto meglio, mi tengo in contatto continuo con il medico di famiglia e il cardiologo del CNR, ai quali mi rivolgo e rompo le scatole. Vado avanti a pasticche che scandiscono la velocità del cuore, la coagulazione del sangue e gli orari dei pasti e della giornata. E devo sottopormi a continue analisi del sangue e comunicarle al medico per dosare le pasticche: una intera, tre quarti, metà. Ho ripreso a camminare, a guidare la macchina, ad uscire. Un po’ di fatica, difficoltà con la gabbia toracica che devo portare di nuovo alla sua elasticità e capienza: per questo mi hanno dato un aggeggio in cui inspirare e soffiare con una pallina maledetta che devo tener su inspirando e un misuratore che si deve alzare più che si può. Dopo mi gira la testa e mi sento un po’ un coglione, ma lo deve fare. Il problema sarà non sentirsi invalido. Anche se so che non sarà più come prima: addio ai bagni nell’acqua gelida dei fiumi della Lunigiana, alle lunghe nuotate al mare o in piscina, addio alle camminate impegnative in salita e discesa! Acquisisco una volta per tutte la condizione di anziano. Senesco, ma se n’esco va bene. Non potrò più rincorrere i miei nipotini in bici, sollevarli di peso, ma vorrei poterli di nuovo badare un po’, portarli al parco, andare in ferie con la compagna e camminare nei boschi. Tornare alla vita o quel che ne resta.
Ora sono qui che scrivo. Questa “storia” andava raccontata, mi chiamava. Al solito, mi sono dilungato e se siete arrivati fin qui in questi tempi di brevitas, bravi, i miei venticinque lettori! Mi preme ringraziarvi e assicurarvi che di questo prolisso racconto gli eventi e le storie sono veri, ancorché filtrati dal setaccio talora fantasioso e imperfetto della memoria, i nomi no, sono stati cambiati per rispetto della privacy. E se siamo finalmente giunti alle conclusioni e ai ringraziamenti, dico grazie di cuore, o quel che ne è stato fatto, alla mia compagna e sua figlia, ai miei figli, a fratelli e sorella, che mi hanno accudito, agli amici e a coloro che si sono interessati di me. Ai medici che mi hanno curato, operato e assistito, al personale sanitario. Non solo, come ho già detto, la sanità pubblica è una grande conquista da difendere e potenziare, ma siamo fortunati ad avere centri di eccellenza come quelli del cuore, in Toscana. La vita vale per il valore che le diamo, non se ne capisce spesso il senso, non riusciamo a spiegarci il destino, il caso, quel che vogliamo o ci viene imposto, ma a coloro che ce la rendono migliore e più degna di essere vissuta, che ce la curano e ce la salvano dobbiamo essere grati.
Marco Celati
Pontedera, Giugno 2024
____________________
“Non potho reposare”, Andrea Parodi
https://youtu.be/lVgflKuQVwg?si=bU20Vh6-QkW4MTRM
“No potho reposare”, Gianna Nannini
https://youtu.be/j55QZapD5iA?si=DFGkgj6DTtcjcYfC
Marco Celati