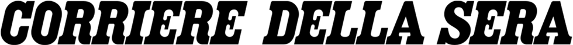La Cop 30 di Belem giorno per giorno
di Adolfo Santoro - Sabato 22 Novembre 2025 ore 08:00

Vi propongo un sunto della cronistoria della Cop 30 di Belem per come l’ha vissuta Andrea Grieco, divulgatore gentile di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.
GIORNO 1. 11 novembre 2025. La Cop 30 prende il via: sarà la Conferenza della finanza.
È cominciata la Cop 30, nel cuore dell’Amazzonia e il simbolismo è forte: la foresta più grande del Pianeta come scenario del più importante negoziato sul clima. Lula l’ha voluta qui, in casa sua, per riportare il clima dove la natura parla. Ma appena si arriva al centro congressi, ancora un mezzo cantiere, si capisce che la sfida di questa Cop sarà più politica che poetica.
Il primo dato è già arrivato: l’Unfccc ha pubblicato l’aggiornamento del Ndc Synthesis Report, il documento che mette insieme tutti gli impegni climatici nazionali e c’è una buona notizia: le emissioni globali previste al 2035 sono in calo del 19-24% rispetto al 2019. Un segnale, piccolo ma reale, che la curva delle emissioni sta finalmente iniziando a piegarsi. La cattiva notizia è che non basta: con questi ritmi, il riscaldamento globale a fine secolo resta tra +2,2°C e +3,4°C, ben lontano dall’obiettivo di 1,5°C fissato a Parigi.
Ed è qui che si capisce il senso politico di questa Cop: non si tratta più solo di promettere tagli, ma di implementare, di far funzionare davvero le politiche già scritte sulla carta, come ricordato dal direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini, la Cop 30 non è una partita da guardare in casa, ma da giocare in campo. E la differenza, questa volta, la farà la finanza.
Tutti ne parlano, giornalisti e negoziatori: questa è la Cop della finanza. Dopo l’accordo di Baku, che aveva fissato a 300 miliardi di dollari l’anno i fondi per l’azione climatica, il tema ora è come (e da chi) arrivare agli almeno 1.300 miliardi necessari per mitigazione e adattamento. Non è solo una questione economica, ma di responsabilità: il parere della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, pubblicato a luglio, ha chiarito che i Paesi che non agiscono abbastanza potrebbero essere ritenuti giuridicamente responsabili dei danni causati dal cambiamento climatico. In altre parole: non è più solo un problema di fondi, ma di giustizia internazionale.
Fuori dai padiglioni, intanto, c’è uno spettacolo che racconta più di tante plenarie: Belém è piena di auto elettriche cinesi, le navette che accompagnano delegati e giornalisti sono fornite da due dei principali produttori della Cina, un modo per dire, senza dirlo, che la transizione si gioca anche sul terreno industriale. È un’immagine che vale più di molti discorsi: il Paese che emette più CO₂ al mondo è anche quello che esporta la maggior parte delle soluzioni “verdi”. La Cina è responsabile di circa 12 miliardi di tonnellate di CO₂ all’anno, più di Usa e Unione europea messi insieme, ma al tempo stesso è leader globale nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica. Eppure, la Cina non sarà presente, così come gli Stati Uniti e l’India.
Gli equilibri della Cop 30 in pillole:
L’Unione europea ha confermato l’obiettivo di -90% di emissioni entro il 2040, ma sta rallentando: servirebbero 500 miliardi di euro in più ogni anno per restare in rotta.
Gli Stati Uniti, con l’uscita di Trump dall’Accordo di Parigi, rischiano di ridurre le emissioni di appena 7-19% entro il 2035, molto meno del previsto.
La Cina, invece, continua a crescere in emissioni totali ma migliora la propria efficienza e guida la corsa alle tecnologie pulite.
Insomma, chi inquina di più sta anche costruendo le soluzioni, e chi si proclamava leader climatico ora è in fase di difesa.
Cosa aspettarsi oggi:
Oggi si entra nel vivo dei negoziati, con tre nodi da sciogliere:
- la definizione del nuovo obiettivo globale sulla finanza climatica;
- l’adozione del Global Goal on Adaptation, che è un quadro globale per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come stabilito dall'Accordo di Parigi (Articolo 7)
- le regole per i mercati del carbonio.
Già dai discorsi di apertura della prima giornata si è percepito che sarà una vera e propria conferenza sulla fiducia tra Nord e Sud del mondo, tra promesse e realtà, tra chi ha già i mezzi per cambiare e chi ancora li aspetta.
GIORNO 2. 12 novembre 2025. Abbiamo un’agenda e il nuovo protagonista è l’adattamento
La giornata di ieri si è chiusa con il primo piccolo “brivido” di questa Cop 30: l’approvazione dell’agenda. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è affatto.
Per partire davvero, una Cop ha bisogno che tutti i Paesi approvino per consenso l’elenco dei temi da negoziare nelle due settimane: quali capitoli si aprono, quali no, cosa ha spazio formale e cosa viene rimandato ai corridoi o ai side event. Senza agenda non si può discutere di testi, non si possono creare gruppi di lavoro, non si possono adottare decisioni. In passato, su questo si sono consumati veri e propri agenda fight, con ore, a volte giorni, persi in plenaria su una singola riga di testo.
Ieri il rischio c’era anche a Belém: diversi gruppi di Paesi avevano chiesto di inserire nuovi punti, soprattutto su finanza e risposta al deficit di ambizione degli Ndc (ovvero i piani nazionali di riduzione delle emissioni) rispetto alla soglia di 1,5 °C. Alla fine, la presidenza brasiliana ha scelto una strada di compromesso: le nuove proposte (su finanza, commercio, misure unilaterali, risposta al gap di ambizione, armonizzazione dei metodi di rendicontazione) verranno discusse in consultazioni della presidenza fino a mercoledì, quando in plenaria sarà chiarito dove e come troveranno spazio nel negoziato.
Insomma l’agenda c’è e la Cop 30 può davvero cominciare.
Alla Cop 30 ritorna l’adattamento climatico
Se negli ultimi anni il lessico delle Cop è stato dominato da neutralità climatica, phase-out dei fossili, Ndc al 2035, qui a Belém si sente ripetere un’altra parola: adattamento. Non è un tema nuovo, ma è nuova la sua centralità. A Belém, l’adattamento non è più la cenerentola del negoziato: se ne parla nei testi, nelle plenarie, nei panel dei ministri, nei corridoi delle Ong. Il messaggio è chiaro: non basta promettere meno emissioni, bisogna anche proteggere chi sta già pagando il prezzo della crisi climatica. Il nuovo Adaptation Gap Report dell’Unep ha aggiornato la fotografia:
- i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno tra 310 e 365 miliardi di dollari l’anno entro il 2035 solo per adattarsi agli impatti climatici;
- la finanza pubblica internazionale per l’adattamento oggi è intorno ai 26 miliardi di dollari l’anno: meno di un 12esimo del fabbisogno stimato.
Tema del giorno: le città
Il programma ufficiale della Cop 30 prevede che il 10 e l’11 novembre siano dedicati, tra gli altri, ai temi di adattamento, città, infrastrutture, acqua, rifiuti, governi locali e bioeconomia. Nel secondo giorno, in particolare, sindaci, governatori e amministratori locali hanno discusso di come trasformare gli impegni nazionali (gli Ndc “3.0” che i Paesi dovranno presentare entro il 2025) in politiche concrete sul territorio.
Altro da sapere sui negoziati?
Global Goal on Adaptation: continua il lavoro tecnico per ridurre l’attuale proposta di circa 100 indicatori, cercando un equilibrio tra la necessità di avere parametri comuni e quella di rispettare la forte dimensione locale dell’adattamento. Gli indicatori serviranno sia per misurare i progressi sia per guidare l’allocazione della finanza.
In sintesi, dopo aver ottenuto l’agenda, la Cop 30 è entrata nel vivo con un messaggio chiaro: la crisi climatica si gioca sempre più dove le persone vivono, nelle città, e su come riusciremo ad adattarci senza rinunciare a ridurre rapidamente le emissioni. Se questa Cop saprà tenere insieme queste due dimensioni, potrà davvero essere come dicono molti qui a Belém la Cop dell’attuazione, non solo delle promesse.
GIORNO 3. 13 novembre 2025. Belém ha l’energia: questa Cop può davvero fare la storia
Ieri si è sentito forte: questa Cop potrebbe davvero essere storica. Non solo nei testi, ma fuori dai padiglioni. Si è tornati a manifestare liberamente intorno alla conferenza, l’ultimo ricordo è della Cop 26, segno di uno spazio pubblico riaperto dopo anni di summit ospitati in Paesi che non rendevano facile manifestare.
Nel frattempo è arrivata la flotilla indigena: barche, comunità, amministratori, movimenti che hanno percorso il Rio delle Amazzoni, in un’iniziativa che ha riunito circa 60 organizzazioni indigene non solo della Panamazzonia, ma anche del resto del Continente. Il gruppo ha completato un viaggio fluviale di oltre 3mila chilometri, iniziato a Puerto Francisco de Orellana (Ecuador), e proseguito attraverso il Perù e il Brasile, con l’obiettivo di consegnare un messaggio ai leader mondiali che parteciperanno alla Cop 30. La flotilla porta a Belém tre richieste principali: fermare ogni nuova esplorazione petrolifera e di gas in Amazzonia; garantire la protezione integrale dei popoli indigeni in isolamento; creare un fondo climatico globale, diretto e trasparente, che riconosca i popoli indigeni come partner strategici nell’azione per il clima. La prospettiva è quella di mettere l’Amazzonia al centro della lotta per la giustizia climatica ed esigere la fine dell’uso e dello sfruttamento dei combustibili fossili.
Dietro le quinte, la presidenza è al lavoro notte e giorno su una cover decision, cioè iltesto politico finale, che, già al terzo giorno, esiste in bozza. L’obiettivo non è piccolo: un nuovo mandato politico sotto l’Accordo di Parigi con roadmap, date e scadenze per un’uscita graduale e ordinata dai fossili entro un decennio, allineata a scienza e obiettivi di Parigi e facendo leva sul testo del Global Stocktake 2023. Il linguaggio ruota attorno alla giusta transizione e al ruolo della scienza.
Altro da sapere sui negoziati?
- La Baku to Belém Roadmap è, in pratica, il piano di percorso su come i Paesi dovrebbero organizzarsi per trovare e mobilitare i soldi necessari alla finanza climatica nei prossimi anni. Sarà discussa sabato. Alcuni Paesi vogliono che a guidarla ci sia anche un coinvolgimento diretto dei ministri delle Cop 29 e 30, così da arrivare già a Belém con proposte operative concrete. Parte dei Paesi sviluppati però frena, mentre il G77 ricorda che senza una vera implementazione la roadmap rischia di rimanere solo sulla carta e non colmare il divario finanziario legato al nuovo obiettivo globale di finanza (Ncqg). Sul tavolo c’è anche la richiesta dei Paesi meno sviluppati di triplicare i fondi per l’adattamento, arrivando a circa 120 miliardi di dollari l’anno entro il 2030: per alcuni donatori significherebbe riaprire negoziati delicati, ma per i più vulnerabili è l’unico modo per dare sostanza al Global Goal on Adaptation.
- Transizione equa: il G77 (134 Paesi + Cina) propone un Just Transition Mechanism. In parallelo cresce una convergenza – tra Paesi in via di sviluppo e sviluppati – sulla necessità di criteri sociali e ambientali nella catena dei minerali critici, perché decarbonizzare non può voler dire spostare ingiustizie altrove.
- Roadmap di uscita dai fossili e stop alla deforestazione: il presidente della Cop, Correa do Lago, ha dichiarato che: non è un punto in agenda e non è stato formalmente sollevato alla Cop. Il dibattito si sposta così sul piano politico più che su quello tecnico dell’agenda.
Belém con la Cop 30 respira democrazia e conflitto e questa ambivalenza sta tenendo vivo il negoziato. Se la scommessa della cover decision reggerà, la Cop 30 può davvero spostare l’asticella: una tabella di marcia credibile su fossili e giusta transizione, mentre adattamento e finanza escono dalla retorica e diventano compiti datati.
GIORNO 4. 14 novembre 2025. Belém scalda i motori: la Cop si complica, ma il quadro prende forma
Mentre scrivo da una Belém afosa, arriva l’ennesima mail dai corridoi della Cop. È tardi, molto tardi, eppure si continua a negoziare come se fossimo alla notte finale. In realtà siamo solo all’inizio del giorno 5. In una Cop che corre veloce, questa intensità dice già tutto: i nodi stanno emergendo e non sono marginali.
Il primo riguarda l’adattamento: uno dei risultati più attesi da Belém sarebbe un nuovo blocco di indicatori per monitorare i progressi dei Paesi su resilienza e impatti. Ma il confronto si sta rapidamente trasformando in un fronte di tensione. Un gruppo di Paesi africani e arabi sta chiedendo di rinviare la decisione al 2027. La posizione nasce da un punto chiaro: senza certezze finanziarie, gli indicatori rischiano di diventare solo un elenco di compiti impossibili da realizzare.
Il timore di fondo è che gli attuali criteri finiscano per conteggiare anche fondi nazionali già insufficienti, mentre il vero nodo è l’assenza di risorse internazionali. La richiesta è dunque di costruire gli indicatori con più tempo e più realismo, per renderli coerenti con le capacità dei Paesi di pianificare e pagare l’adattamento. Una dinamica che potrebbe frenare l’ambizione brasiliana di fare della Cop 30 la Cop dell’adattamento.
E i fossili?
Il messaggio lanciato da Lula il primo giorno, ovvero costruire una roadmap globale di transizione dai combustibili fossili, non è rimasto lettera morta. Anzi, sta prendendo forma. Un gruppo sempre più ampio di Paesi, dalle economie avanzate a quelle emergenti, ha iniziato a coordinarsi per portare il tema nel pacchetto finale della Cop, anche se non compare nell’agenda ufficiale. L’idea di base è semplice: senza un orientamento chiaro, condiviso e pluriennale, la transizione rischia di procedere a macchia di leopardo. Serve una bussola comune che guidi l’uscita dai fossili e che tenga insieme scienza, giustizia sociale e tempistiche compatibili con l’obiettivo 1,5°C. La sfida è ora trasformare il sostegno politico in numeri concreti.
Altro da sapere sui negoziati?
Partecipazione Indigena: Belém è la Cop con la più ampia partecipazione indigena di sempre: circa 2.500 persone da tutto il Brasile e dal resto del mondo. Eppure, solo una piccola parte riesce ad accedere alla Blue Zone, l’area dove si negozia davvero. Il risultato è un paradosso: massima presenza, minimo potere.
Sul Mitigation Work Programme è arrivata una spinta forte dai piccoli Stati insulari, che ricordano a tutti che senza impegni chiari non esiste futuro per nessuna agenda climatica. La bozza circolata stamattina riconosce il ruolo della scienza, della soglia 1,5°C, delle foreste e dell’economia circolare, ma resta vuota di impegni vincolanti. Un testo che, così com’è, rischia di non spostare l’ago della bilancia.
L’articolo 2.1(c) dell’Accordo di Parigi dice questa cosa molto concreta: i soldi – investimenti pubblici, privati, finanziamenti, prestiti – devono andare nella direzione giusta, cioè verso un’economia che inquina meno e che è preparata agli impatti climatici. Sul tema sono ripresi i negoziati, i Paesi alla Cop hanno accettato di iniziare almeno a scrivere una prima bozza che raccolga tutte le posizioni. Non è un accordo, né un testo finale. Ma è un segnale che qualcosa si muove.
Se la presidenza della Cop 30 riuscirà a tenere insieme queste tensioni, si potrebbe davvero raggiungere un buon risultato!
GIORNO 5. 15 novembre 2025La Cop comincia a scoprire le sue carte
Questo è il bollettino del quinto giorno della Cop 30. Siamo ormai alla fine della prima settimana e in venue si avverte quella frenesia tipica dei venerdì di negoziato: si corre, si entra e si esce da una sala all’altra, e mentre scrivo praticamente ovunque c’è ancora qualcuno che sta negoziando. Domani dovranno chiudersi i lavori degli organismi tecnici, quindi il tempo si è compresso e tutto sta succedendo velocemente.
Fuori dalle sale si è diffusa una sensazione nuova: sempre più governi stanno parlando apertamente dell’idea di costruire una roadmap per la transizione dai combustibili fossili. Non è nell’agenda ufficiale, ma il tema è entrato nella conversazione politica in modo chiaro. Per molti Paesi, questa Cop potrebbe essere il punto di partenza di un processo pluriennale che finalmente definisca un percorso comune, credibile e sostenibile per uscire dai fossili.
Nel frattempo, nelle stanze più politiche circola un messaggio: non tutto dovrà essere visibile quest’anno, ma è importante che il processo inizi. Si sottolinea che serve una guida, una bussola, un impegno collettivo che vada oltre le dichiarazioni di intenti. E in parallelo si apre un fronte nuovo: per la prima volta a una Cop si parla di come rendere sostenibile e giusta anche l’estrazione dei minerali critici per la transizione. È entrato un primo linguaggio in una bozza sul Just Transition Work Programme, ma non è ancora chiaro se sopravviverà al testo finale.
A dominare davvero la giornata è stato il negoziato sul Global Goal on Adaptation: si capisce che sarà uno dei pezzi centrali del pacchetto finale della presidenza brasiliana. Lo si nota dal fatto che in altre sale, mentre si discuteva di questioni tecniche come l’Articolo 6.4, alcuni delegati ripetevano che era inutile insistere su dettagli marginali finché il tavolo GGA non avesse trovato una direzione. È un segnale chiaro: sta nascendo un pacchetto complessivo, probabilmente costruito intorno a tre blocchi:
- giusta transizione
- finanza per l’adattamento
- e, se ci saranno i numeri, un impegno politico sulla transizione dai fossili.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che iniziano ad arrivare i primi segnali di nervosismo, alcuni Paesi stanno già cercando di frenare, come l’Arabia Saudita che oggi, in una sessione informale, ha espresso opposizione netta a ogni riferimento alla scienza, all’Ipcc e alla soglia di 1,5°C. Un tentativo chiaro di indebolire il linguaggio.
La comunità scientifica risponde con decisione: 1,5°C non è una temperatura dell’anno, ma una media pluriennale. E anche se l’anno scorso abbiamo superato temporaneamente la soglia, l’obiettivo resta scientificamente valido, ed è ancora politicamente essenziale. È proprio questo il messaggio che società civile ed esperti stanno difendendo qui a Belém.
Domani i gruppi tecnici dovranno chiudere, poi entreranno in scena i ministri: è lì che questa Cop inizierà davvero.
GIORNO 6. 16 novembre 2025. Una giornata chiusa solo sulla carta
La Cop 30 ufficialmente era chiusa, ma a Belém non si è fermato quasi nulla. La domenica, che in teoria doveva essere una pausa, si è trasformata in una giornata di negoziati tecnici a porte semichiuse, con diversi gruppi di lavoro che hanno continuato a lavorare su testi ancora molto aperti.
Nonostante non ci fossero plenarie, si è respirata un’atmosfera particolare: più silenziosa, ma anche più nervosa. Molti team negoziali hanno usato queste ore per rivedere posizioni, ripulire testi, ricalibrare strategie in vista della settimana ministeriale.
Il momento politico più importante della giornata è arrivato però fuori dalle sale ufficiali: il presidente della Cop 30 è andato a incontrare direttamente le comunità indigene, in seguito alle proteste dei giorni precedenti e alla crescente pressione per mettere la loro agenda al centro del negoziato.
L’incontro si è concluso con la firma di una dichiarazione d’impegni: un documento simbolico ma significativo, in cui la presidenza si impegna a:
- rafforzare la partecipazione indigena nei processi decisionali;
- riconoscere il ruolo dei popoli indigeni nella protezione dell’Amazzonia;
- lavorare per includere meglio i loro diritti e le loro priorità nelle decisioni finali.
Un gesto importante, soprattutto perché arriva proprio nel giorno di pausa, segnale che la presidenza vuole evitare fratture e arrivare alla settimana politica con un terreno più stabile.Non ci sono grandi notizie su nuovi testi, ma è stata una giornata utile per preparare il terreno ai ministri che arrivano oggi.
La sensazione generale è che la Cop entri ora nella fase decisiva con una pressione maggiore su foreste, adattamento e transizione energetica.
GIORNO 7. 17 novembre 2025. La corsa finale è partita, ora ogni ora e ogni virgola conta
Il giorno sette è ripartito dopo la pausa di domenica e, mentre scrivo, qui è quasi ora di pranzo. Ma da stamattina è cambiato tutto: i corridoi si sono riempiti in un attimo, la Blue Zone è piena come non l’avevo ancora vista e c’è la sensazione che la Cop stia davvero entrando nella sua fase più serrata. I ministri stanno arrivando a ondate, la prima plenaria è iniziata prestissimo e fuori dagli edifici si corre.
L’ingresso è completamente blindato dall’esercito, da stamattina circola voce che potrebbe esserci una nuova manifestazione indigena per incontrare Lula, e la tensione si avverte nell’aria. È quella settimana lì: quella in cui tutto si può sbloccare, ma anche quella in cui tutto può complicarsi.
La prima settimana di Cop è finita, ma con una lunga lista di questioni ancora aperte. Per tentare di fare ordinare, ieri sera il Brasile ha pubblicato un documento che riassume le posizioni e le possibili strade da seguire su vari nodi rimasti fuori dall’agenda ufficiale: ambizione verso 1,5°C, finanza, misure commerciali legate al clima. È un tentativo di preparare il terreno prima dell’arrivo dei ministri.
Dentro i negoziati, però, il passo resta lento:
- sugli indicatori per l’adattamento si è ancora lontani da un accordo;
- la giusta transizione avanza piano, frammentata tra priorità diverse;
- l’idea di una roadmap globale per uscire dai combustibili fossili continua a crescere, anche se nessuno l’ha messa formalmente nell’agenda.
È la classica dilatazione delle Cop: si va avanti, ma niente è ancora davvero deciso.
Cop 32: Addis Abeba c’è!
La notizia è ora ufficiale: la Cop 32 si terrà ad Addis Abeba, in Etiopia, nel 2027. Un riconoscimento importante per l’Unione Africana, che avrà la sua Cop “di casa” proprio mentre il continente rivendica più spazio nei negoziati globali. Intanto Australia e Turchia continuano a contendersi la Cop 31. Secondo alcune delegazioni europee, l’Etiopia starebbe spingendo per rallentare i progressi sull’adattamento qui a Belém, così da arrivare alla Cop 32 con un’agenda forte già pronta e rivendicare i risultati come una vittoria politica.
In pratica: un ostruzionismo tattico attorno al Global Goal on Adaptation.
Il problema è che questo rischia di indebolire proprio Belém, che sarebbe dovuta essere la Cop dedicata alle foreste, alla resilienza e all’adattamento. E adesso tocca al Brasile provare a tenere insieme ambizione e manovre diplomatiche tutt’altro che semplici.
Altri punti aperti
Sul Fondo Perdite e Danni si continua a girare intorno alle stesse domande: chi paga, quanto, con quali regole. I Paesi più vulnerabili stanno chiedendo chiarezza, ma qui nessuno vuole scoprirsi troppo presto. È uno dei capitoli che rischia di trascinarsi fino alle ultimissime ore.
Il lavoro sul pacchetto della transizione giusta procede, anche se a piccoli passi. Le differenze tra Paesi restano evidenti: c’è chi vuole un testo più politico e chi lo vuole più operativo, chi chiede un forte riferimento alla scienza e chi spinge su giustizia sociale e lavoro.
Cresce l’attenzione sui Piani nazionali di adattamento, considerati una delle leve più concrete per rendere reali gli impegni sul clima. Ma senza un accordo sugli indicatori e senza risorse certe, il rischio è che tutto resti incompiuto. Ed è proprio ciò che il Brasile vuole evitare.
Il negoziato sui mercati del carbonio resta uno dei più tecnici, ma anche uno dei più politicizzati. Si discute di metodologie, integrità ambientale, supervisione. E ogni parola è oggetto di scontro politico.
E adesso?
Con l’arrivo dei ministri si entra nella fase in cui i testi iniziano a cambiare ogni poche ore, i corridoi diventano più importanti delle sale ufficiali e le notti si fanno più lunghe. Il Brasile punta a un risultato forte, ma la strada è piena di incastri diplomatici, rallentamenti strategici e nuove alleanze che si formano all’ultimo.
La sensazione, però, è chiara: da oggi, ogni ora pesa.
GIORNO 8. 18 novembre 2025. Non una decisione, ma due
L’avevamo detto ieri: questa è la settimana liquida, quella in cui gli annunci si moltiplicano, gli equilibri saltano e le strategie cambiano forma nel giro di poche ore. E infatti ieri sera è arrivata la notizia più grande dall’inizio della Cop: il presidente della Cop 30, André Corrêa do Lago, ha deciso di rivoluzionare il metodo di lavoro per chiudere questa conferenza. Non una decisione finale unica, come da tradizione, ma due pacchetti distinti.
Ecco cosa succederà:
Pacchetto A: conterrà le decisioni più importanti della Cop, quelle che hanno un peso politico vero: adattamento, finanza, giusta transizione, mitigazione e – ormai quasi certo – un riferimento al transitioning away dai combustibili fossili.
Pacchetto B: raccoglierà i temi più divisivi o meno maturi, probabilmente con una forma giuridica più debole (una nota? una serie di conclusioni?).
Una scelta inedita, ma perfetta per capire fin dove si spinge il consenso e dove invece cominciano le linee rosse. È anche un modo per disinnescare ostruzionismi e blocchi tattici: un terreno molto familiare a chi segue le Cop da anni. Il tutto mentre la Cina sta tentando un’operazione diplomatica ambiziosa: tenere dentro Russia e Arabia Saudita in un compromesso che includa, per la prima volta nella storia delle Cop, un riferimento chiaro all’uscita dai combustibili fossili. Missione non semplice, ma in corso.
Nel frattempo nelle stanze dei negoziati…
Le fratture che hanno bloccato il negoziato sul Global Goal on Adaptation nella prima settimana sono rimaste immutate. Lunedì si è dovuti ricorrere a un round di negoziato informal-informal (nei corridoi o al bar): spesso l’unico modo per parlare con più libertà quando i testi entrano in stallo. In parallelo, lo stallo sull’adattamento si porta dietro anche il negoziato sulla finanza per l’adattamento. Il nodo è ben noto: i Paesi vulnerabili chiedono di arrivare ad almeno 120 miliardi di dollari l’anno entro il 2030. Oggi siamo intorno ai 26. Gli sviluppati frenano, ma il tempo per tirarla lunga è finito: nei prossimi giorni saranno i ministri a dover prendere una posizione chiara.
Lunedì il negoziato sul Gender Action Plan si è fermato subito. Prima sulla questione dei dati: disaggregati per genere o per sesso? Poi sul tema più politico: quanto le strategie climatiche debbano integrare in modo esplicito le differenze di genere. Domande che sembrano tecniche, ma che in realtà misurano la distanza tra due visioni: quella che considera la giustizia di genere centrale nelle politiche climatiche e quella che la relega a un dettaglio marginale.
Sul Fondo Perdite e Danni ci sono divergenze profonde: il Gruppo Arabo chiede riferimenti molto specifici a un paragrafo della decisione della Cop 28; i Paesi vulnerabili criticano il paragrafo 13 della nuova bozza, temendo che limiti il mandato del Fondo; l’Ue chiede un testo snello, non duplicativo rispetto al Board.
I co-facilitatori hanno convocato un negoziato informal-informal su tre temi: decisioni Cop 28, pledges e risorse, modalità di accesso. È uno dei dossier che potrebbe arrivare fino all’ultima notte.
Domenica notte la Presidenza ha pubblicato una nota sui temi senza una sede formale nei negoziati: gap verso 1,5°C, finanza, misure commerciali, trasparenza. L’idea era raccoglierli in una mutirão decision.
Ma ieri la strategia è cambiata: tutto finirà dentro il primo pacchetto politico di Belém, che la presidenza vuole approvare entro metà settimana. Il secondo pacchetto seguirà a ruota.
Unfccc e presidenza lo hanno detto chiaramente: niente tatticismi, niente ritardi (per evitare la situazione di stallo dell’anno scorso).
GIORNO 9. 19 novembre 2025. Ed è così che ricomincia la salita…
I negoziatori della Cop 30 sono tornati in venue con una lista di incontri che non lascia spazio al respiro. Il presidente della Cop 30 lo ha ripetuto ovunque: vuole chiudere tutto entro venerdì, vuole che la Cop dell’Amazzonia entri nella storia.
Ma chi frequenta le Cop lo sa: questo è il momento in cui l’energia crolla e il testo esplode. È il classico punto basso della conferenza, quando la fine si avvicina ma le parentesi (le parti fragili, instabili, in disaccordo) restano ovunque. La prima bozza circolata ieri mattina ne è la prova: pagine e pagine di opzioni, alternative, formulazioni tra parentesi quadre. Nessuno ci vede ancora un atterraggio chiaro.
Non possiamo rafforzare l’adattamento se non arrivano i mezzi, mi ha detto una negoziatrice del Senegal. Ed è esattamente il nodo che inchioda quasi tutto.
Cosa dice la bozza?
L’immagine scelta dal presidente è ormai ovunque: entrare in modalità mutirão, quel momento in cui una comunità si mette allo stesso tavolo e lavora finché il lavoro non è fatto. La presidenza dice che la prima settimana ha dato segnali incoraggianti. Ora però serve un salto. Da ieri pomeriggio è partita la shuttle diplomacy: giri rapidi, stanza per stanza, per capire dove cedere e dove resistere.
Obiettivo: pubblicare testi rivisti mercoledì mattina e chiudere il pacchetto politico già domani. Per far spazio al negoziato, una parte degli eventi collaterali - forum giovanile, dialogo di Baku sull’adattamento, tavole rotonde ministeriali - è stata spostata a mercoledì e giovedì.
Sul discusso Articolo 9.1 (il sostegno economico ai Paesi in via di sviluppo), gli sviluppati hanno fatto un mezzo passo: più prevedibilità, volumi più chiari, possibilità di contribuire all’obiettivo dei 300 miliardi l’anno del nuovo Ncqg.
Sul Fondo Perdite e Danni invece siamo fermi: posizioni distanti, sensibilità diverse, strategie che non si incastrano.
Se l’aumento della finanza non sarà credibile, gli indicatori dell’Obiettivo Globale sull’Adattamento rischiano di rimanere un esercizio teorico, sconnesso dalle realtà dei Paesi più colpiti. I Paesi in via di sviluppo chiedono equilibrio: adattamento, mitigazione, perdite e danni devono pesare allo stesso modo nel nuovo obiettivo finanziario globale. E chiedono un impegno netto. Tra le proposte: triplicare la finanza per l’adattamento entro il 2030, arrivando ad almeno 120 miliardi l’anno.
Arrivano nuovi fondi (ma l’Italia non c’è)
Buone notizie dal Fondo per l’Adattamento: ieri sono stati annunciati nuovi contributi per 133 milioni di dollari. Germania, Spagna, Svezia, Irlanda, Lussemburgo, Svizzera, Vallonia, Corea del Sud e Islanda hanno messo risorse fresche. L’Italia non contribuisce dal 2021. La richiesta di continuità e prevedibilità resta una delle più ripetute nei corridoi.
Nel frattempo oltre 80 Paesi si impegnano per uscire dai combustibili fossili. L’idea, lanciata dal Brasile e rilanciata da Lula, ha raggiunto quota 82 Paesi favorevoli. Tra loro Stati europei, piccole isole, grandi economie emergenti. Ma il consenso non è affatto garantito.
Oggi è il giorno di Lula: il suo arrivo è considerato da molti la leva politica necessaria per spingere gli ultimi compromessi e far chiudere il pacchetto con un accordo forte. E intanto il testo continua a cambiare sotto i nostri occhi, è una corsa contro il tempo e nei corridoi si sente chiaramente.
GIORNO 10. 20 novembre 2025. La speranza è l’ultima a morire
Oggi è una giornata strana, quasi sospesa, qui nella venue si avverte un clima diverso: non c’è frenesia, non c’è caos, c’è attesa. Lunga, pesante, condivisa. Tutti guardano l’orologio chiedendosi la stessa cosa: arriverà una nuova bozza stasera oppure no? La verità è che molti non ci credono più. I negoziati avanzano con una lentezza esasperante, e questa incertezza si riflette nei volti dei delegati, più tesi che stanchi.
Intanto, nella venue è arrivato Antonio Guterres. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è qui per dare il famoso push politico. Se servirà a qualcosa, lo capiremo presto. Per ora la sua presenza aggiunge solo ulteriore aspettativa.
Durante un breve incontro con la stampa, gli hanno chiesto che cosa aspettarsi dal coinvolgimento degli Stati Uniti, soprattutto in un momento in cui la COP è praticamente bloccata. Lui ha risposto con un sorriso stanco e una frase che è rimbalzata ovunque: La speranza è l’ultima cosa a morire.
Una frase semplice, quasi proverbiale, ma che dice molto.
Nel frattempo, i negoziati non si sono mai fermati, si è lavorato tutta la notte. Il mutirão nasce con un obiettivo unico: chiudere tutto entro domani. Ma stamattina era evidente che siamo ancora lontani da un equilibrio stabile.
Cosa succede al negoziato
Adattamento: i negoziatori hanno passato ore a cercare un punto d’incontro sul tema che blocca l’intero pacchetto: come finanziare la resilienza dei Paesi vulnerabili. I ministri latinoamericani hanno fatto un appello compatto: senza un aumento concreto della finanza per l’adattamento, gli indicatori del Global Goal on Adaptation non hanno alcun senso. La regione non vuole che una Cop in Amazzonia si chiuda senza progressi chiari su questo fronte. Il problema è sempre lo stesso: i Paesi ricchi dovrebbero dedicare una quota consistente dei fondi già promessi (300 miliardi l’anno entro il 2035) proprioall’adattamento. Ma nessuno vuole essere il primo a mettere cifre sul tavolo.
Giusta transizione: la discussione sulla giusta transizione si è complicata ulteriormente. La Cina non vuole che si parli di minerali critici nel testo e sarebbe la prima volta in assoluto in una Cop. La Russia frena qualsiasi riferimento ai diritti umani nelle catene minerarie.
Gender Action Plan: lo stallo è totale. Russia, Arabia Saudita e altri Paesi insistono per inserire una definizione binaria di “genere”, che molte delegazioni europee e latinoamericane considerano inaccettabile. Una questione apparentemente tecnica che sta diventando uno dei simboli della distanza tra visioni politiche inconciliabili.
L’Unione Europea ha trovato una posizione comune sulla roadmap per l’uscita dai combustibili fossili. La proposta vuole: accelerare gli impegni presi a Dubai, ancorare la roadmap alla scienza, basarla sugli NDC, monitorarla annualmente con un rapporto della Presidenza.
È ufficiale: COP31 sarà ad Antalya (con presidenza australiana): Dopo giorni di incertezza, la decisione è arrivata: la prossima COP si terrà in Turchia, con presidenza australiana. Un compromesso che pochi si aspettavano, ma che chiude una delle partite politiche più rumorose delle ultime settimane.
Durante il Food & Agriculture Day, l’Alliance of Champions for Food Systems Transformation ha annunciato tre nuovi ingressi: Colombia, Vietnam e Italia. Un ampliamento che dà respiro a un’agenda che vuole trasformare i sistemi alimentari in veri pilastri di resilienza, mitigazione ed equità.
Insomma,è evidente che il tempo stringe. Questa Cop sta cercando in tutti i modi di trovare un varco tra posizioni che si irrigidiscono mentre tutti aspettano un testo.
E domani, molto probabilmente, vi dirò se il mutirão reggerà o meno.
Ma le comunicazioni di Andrea Grieco arrivano con ritardo, per cui la conclusione la affido al commento di ECCO.
Buongiorno! Venerdì 21 novembre 2025, Belém, Brasile, undicesimo giorno della COP30.
Da calendario oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno della COP di Belém. Non lo sarà. Con buona probabilità, anche quest’anno, serviranno i tempi supplementari. Un tempo extra reso necessario anche dalle conseguenze dell’incendio che ieri, attorno alle 14.00, ha coinvolto alcuni padiglioni della Blue Zone della COP, con successiva evacuazione di tutti i delegati e interruzione dei lavori. I lavori sono ripresi ufficialmente questa mattina e non ci sono stati feriti. Nella delegazione ECCO stiamo tutti e tutte bene e ringraziamo le tante persone che ci hanno scritto in queste ore.
Una nuova bozza della Mutirão Decision – questa notte la Presidenza ha inviato nuove versioni aggiornate dei testi negoziali, secondo alcune fonti in modalità: prendere o lasciare. Tra i nuovi testi compare anche una bozza della Muritao Decision, ovvero l’accordo politico e più simbolico della COP e include: la risposta alla mancanza di ambizione sulla mitigazione, la finanza internazionale e le misure unilaterali sul commercio.
Una bozza che scontenta molti - la Presidenza decide di far partire l’ultima giornata di negoziati da una base comune molto bassa che scontenta già molti Paesi. Se da un lato queste bozze scontentano molti, dall’altro, possono far parte di una strategia della Presidenza per testare le reazioni e raccogliere ulteriori elementi per la costruzione di una bozza finale. Il testo attuale mostra un’ambizione ridotta soprattutto su mitigazione.
La strada verso l’Accordo è in salita - senza miglioramenti sostanziali sale il rischio che alcuni paesi o interi blocchi negoziali preferiscano la soluzione – grave, ma ancora improbabile - del mancato accordo. Sulla mitigazione, il testo attuale prevede spazi in cui i Paesi potranno discutere e avanzare la transizione dai fossili, seppur senza citarli esplicitamente. Questi processi sono il Global Implementation Accelerator (paragrafo 41), un’iniziativa volontaria sotto la guida delle presidenze delle prossime due COP per discutere di come aumentare l’implementazione dei piani nazionali (sia gli NDC che i NAP, i piani per l’adattamento) e la Belém Mission to 1.5 (paragrafo 42), sotto la guida della COP attuale e delle successive due, per riflettere su come accelerare l’implementazione, la cooperazione internazionale e gli investimenti nei piani nazionali.
Sull’adattamento, invece, rimane la chiamata a triplicare i flussi finanziari dai livelli del 2025 entro il 2030. Per rispondere alle richieste di un focus dedicato all’Articolo 9.1, chiesto a gran voce dai Paesi in via di sviluppo, c'è la proposta di istituire un programma di lavoro di due anni per affrontare la questione dei finanziamenti pubblici da parte dei Paesi sviluppati. Solo un breve riconoscimento della Baku to Belem Roadmap per i 1300 miliardi’, senza darne seguito. Infine, su commercio sono previsti dei dialoghi nei prossimi due anni con le agenzie commerciali delle Nazioni Unite per affrontare il tema del commercio e del clima.
Le prossime 24 ore saranno decisive per alzare l’ambizione di questo testo.
I primi contrari - un gruppo di 29 Paesi (tra cui Austria, Belgio, Cile, Colombia, Francia, Germania, Messico, Olanda, Slovenia, Spagna, UK e molti stati insulari) – senza l’Italia – si è già opposto pubblicamente alla bozza, dicendo che non contiene le condizioni minime necessarie per un risultato credibile e, nello specifico, che non possono supportare un risultato che non includa una roadmap sui combustibili fossili e che la mancanza di un percorso per fermare la deforestazione è preoccupante. Questo testo sembra non essere accettabile anche per l’Unione europea.
Un mio piccolo commento finale
Tante chiacchiere per un contentino!? I tre obiettivi principali sono stati clamorosamente mancati: non ci saranno né i 1300 miliardi da mobilitare entro il 2035 per i Paesi in via di Sviluppo, né le risorse per l’adattamento, né l’avvio della transizione che porti all’abbandono dei combustibili fossili. I soldi sono già impegnati nell’armarsi per le prossime guerre. Senza il rispetto di roadmap che neanche esistono l’umanità disumana va a schiantarsi contro il muro della realtà. Mentre i ricchi si godono i festini alla Epstein e la plebe si accontenta del pane – sempre meno – e dei giochi da circo, ogni responsabilità è lasciata alla prossima generazione che, sempre più, si dovrà occupare non del vivere in modo saggio, ma di sopravvivere! Ed, in effetti, è così: se l’uomo non sa salvare se stesso, come può avere l’ardire di salvare la Vita sulla Terra?
Adolfo Santoro